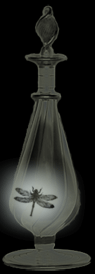
L’analisi è di Adorno e Horkheimer che, nel saggio La dialettica dell’Illuminismo, portano avanti la tesi secondo cui l’illuminismo avrebbe la tendenza a rovesciarsi nel suo contrario, soprattutto nell’asservimento totalitario delle masse, attraverso le lusinghe dell’industria culturale. È chiaro che per i due filosofi della Scuola di Francoforte l’illuminismo non è soltanto una fase storica oramai superata, semmai un passaggio ancora tenacemente aggrappato alla poliedrica società consumistica e globalizzata, e che trova nelle sue idiosincrasie il rovesciamento di se stesso e il controllo degli individui.
La cultura, costruita ad arte da un’industria che edulcora e dolcificando controlla, è ben altro che una parentesi politica, ma è il leitmotiv per un asservimento radicato in cui il tema del sesso e del piacere fine a se stesso è lo strumento che più si presta a questo stesso controllo.
La
Juliette del marchese De Sade è sicuramente una pedina di una
società che la vorrebbe relegata all’interno di un gineceo
conservatore e maschilista eppure, nel suo ribellarsi, Juliette non
fa altro che cadere nella trappola che la vorrebbe libera nei suoi
consumi libidici, libertà che di contro la renderebbe comunque
schiava.
Juliette
è uno stereotipo al contrario: sadica e lasciva incanta se stessa
prima degli altri, l’amore è un concetto troppo grande, troppo
pericoloso per poter essere anche solo bisbigliato. Nell’amore
il piacere era associato alla venerazione dell’essere che lo
procurava; l’amore era la passione propriamente umana,
ma – spiegano ancora Adorno e Horkheimer – nell’adorazione
dell’amante come nell’immaginazione senza limiti di cui era
oggetto da parte dell’amata, si mascherava e idealizzava sempre di
nuovo la servitù effettiva della donna.
I desideri non sono bolle di sapone che svaniscono non guardandole, Freud è stato molto esplicito su questo argomento: le pulsioni non restano sotto al tappeto, né è possibile aspirarle come fossero polvere, ma restano, si contorcono finché non trovano il modo di mostrarsi. Juliette divinizza il peccato, così come la morale e le regole sociali divinizzano la virtù. Ma vizio e virtù sono solo le due facce di un’unica medaglia, e l’uno è il guinzaglio dell’altra.
E l’amore che ruolo ha in tutto questo?
“Nell’epoca della grande industria culturale l’amore è annullato”. I filosofi della scuola di Francoforte non hanno dubbi. “Un tempo la servitù nella casa paterna accendeva nella fanciulla la passione che pareva condurla alla libertà: anche se poi questa non si realizzava nel matrimonio, né al di fuori della casa. Mentre si apre, per la ragazza, la prospettiva del job, le si sbarra quella dell’amore”. Soprattutto in una società in cui la considerazione che un individuo ha di sé cresce proporzionalmente alla sua fungibilità. Il matrimonio rende fungibili, se non altro nella misura in cui la donna viene vista – ancora – come colei che elargisce dedizione, colei che ascolta, che passivamente produce attraverso la cura dell’altro. “Il cristianesimo ha idealizzato, nel matrimonio, come unione dei cuori, la gerarchia dei sessi, il giogo imposto al carattere femminile dell’ordinamento maschile della proprietà”. Ma il gentil sesso ha pagato il culto stilnovistico della donna angelicata con la credenza delle streghe. “Perché la distruzione non ammette eccezioni – dice Juliette – la volontà di distruggere è totalitaria, e totalitaria è solo la volontà di distruggere (…) vorrei che l’umanità avesse una testa sola per avere il piacere di mozzarla d’un colpo”. In questa frase è vivo il marchio della debolezza insita nell’essere donna, ma la debolezza che emerge è sociale non biologica.
“Il modo in cui una ragazza accetta e assolve il sue date obbligatorio, il tono della voce al telefono e nella situazione più familiare, la scelta delle parole nella conversazione e l’intera vita privata, ordinata secondo i concetti della psicoanalisi volgarizzata, attestano lo sforzo di fare di se stessi l’apparecchio adatto al successo, conforme, fino ai moti più istintivi, al modello presentato dall’industria culturale”. L'oggetto si spinge oltre l'alienazione del feticcio, si fa strada in un labirinto fatto di tabù e di stereotipi, diventando esso stesso un feticcio.
Anche
il matrimonio è l'oggettivazione di un sapere che smette di essere
antropologico per ascoltare solo il richiamo delle esigenze sociali.
“Certo che ti farò del male. Certo che me ne farai. Certo che ce ne faremo. Ma questa è la condizione stessa dell’esistenza. Farsi primavera, significa accettare il rischio dell’inverno. Farsi presenza, significa accettare il rischio dell’assenza”. Queste dovrebbero essere le promesse che due innamorati, pronti al matrimonio, dovrebbero farsi l'uno all'altro. E se questo impegno lo adotta il Piccolo Principe perché non precettarlo anche noi?. L'amore eterno è una solo una promessa che difficilmente potrà essere mantenuta. Ma l'appunto non è se è possibile amarsi per tutta la vita, la domanda è perché due persone dovrebbero promettersi di amarsi per tutta la vita? Forse senza un giuramento non riuscirebbero neppure a provarci? L'amore è un prestito ipotecario fatto su un futuro incerto e imperscrutabile, e la realtà è molto più stuzzicante di un matrimonio castrante.
Ogni giorno incontriamo sguardi e odori nuovi e a quegli impulsi, se non ci fosse l'idea che la fedeltà sia una virtù e non una regola sociale, ci lasceremo andare. L'essere umano è una monade che aspetta ti poter aprire la finestra che gli permetterà di osservare il mondo nella sua totalità, nel frattempo maschera questo suo bisogno creando le varie Juliette e le Justine: le due antitesi che però si incontrano in un'unica castrazione sociale.
Ma allora perché l’unica
cosa che cerco è l’amore totale, ridicolo, scomodo, spossante, che
ti consuma e non ti fa pensare ad altro? (cit).








